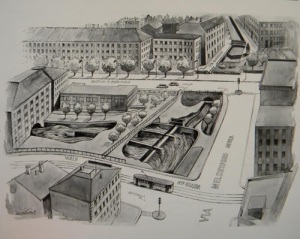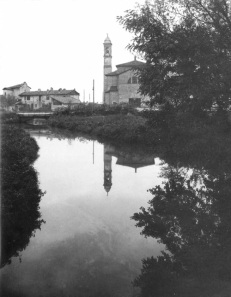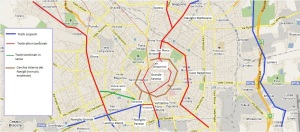| INTERNOTIZIE |
|
. LO SVILUPPO DEGLI
EDIFICI RELIGIOSI CRISTIANI E LO SMANTELLAMENTO DEGLI ORPELLI
PAGANI:MEDIOLANUM SEDE ARCIVESCOVILE SOTTO SANT'AMBROGIO A
Mediolanum la costruzione di grandi basiliche cristiane
avvenne proprio quando
Sant'Ambrogio divenne
vescovo cittadino, anche se l'editto
di Milano del
313
segnò anche l'inizio di profonde e radicali trasformazioni:
l'incoraggiamento del
culto cristiano portò alla metodica distruzione dei
monumenti invisi alle autorità cristiane. A questo proposito è
interessante notare che nella base su cui venne costruito San
Lorenzo sono state riconosciute delle pietre tolte all'anfiteatro
romano, tra la fine del
IV o all'inizio del
V secolo. Queste impiego era giustificato per la presenza di
corsi d'acqua attorno alla zona dove fu costruito San Lorenzo,
poiché era difficile recuperare grandi pietre a Mediolanum,
trovandosi la stessa in una
pianura argillosa. Non a caso il posizionamento delle
famose colonne del
III secolo davanti al cortile, indicano che l'edificazione
delle grandi basiliche di epoca imperiale fu spesso fatta a
spese degli edifici pagani. Vi è da aggiungere che a partire dal
IV secolo, la
liturgia eucaristica mediolanensis (costituendo ora
una giurisdizione metropolitica sulle regioni
Aemilia,
Liguria e le
Alpi occidentali) e quella di
Aquileia (con giurisdizione su
Venetia et Histria), andarono sempre più assomigliandosi
ed accostandosi a quella del vicino
Impero romano d'Oriente.[25] Le prime basiliche di cui si ha notizia, sono
denominate "basiliche doppie" (come la
Basilica vetus del
313-315
o la
Basilica maior degli anni
343-345).[61]
Questa particolare conformazione forse derivava dall'aspetto
degli
horrea romani o, più probabilmente, si trattava, come ad
Aquileia, di chiese separate per i battezzati e per i
catecumeni, essendo il
sacramento battesimale a quell'epoca concesso solo al
completamento di un processo di conversione e purificazione
spirituale. La
basilica di Santa Tecla (le cui rovine sono visitabili sotto
il
Duomo) aveva già comunque un'abside di tipo tradizionale,
che ricorda quelle delle "basiliche" annesse ai grandi palazzi
civili. Una fase successiva corrisponde a quella delle
grandi basiliche della più tarda romanità, a forma poligonale, a
croce, ecc. Questi furono i modelli adottati (oltre che a
Milano) anche per alcune tra le maggiori basiliche più famose
del tardo Impero, come quelle di
Costantinopoli. Sappiamo infatti che Ambrogio fece costruire
varie altre
basiliche, di cui quattro ai quattro lati della città, quasi
a formare un quadrato protettivo, probabilmente pensando alla
forma di una croce. Esse corrispondono all'attuale
S.Nazaro (sul
decumano, presso la Porta Romana, allora era la "Basilica
Apostolorum"), dalla parte opposta
S.Simpliciano, a Sud-Ovest la
Basilica Martyrum (poi lo stesso vescovo vi fu sepolto e
divenne
basilica di Sant'Ambrogio) e infine
S.Dionigi. La Milano imperiale aveva una via trionfale,
fiancheggiata da grandi portici colonnati che usciva da Porta
Romana e proseguiva verso Roma, per terminare (all'altezza
dell'attuale "Crocetta") con un enorme arco celebrativo (molto
più grande dell'arco di Costantino nel Foro romano). STORIA DELLA CANALIZZAZIONE
DI MILANO I progetti per l’imminente Expo del 2015
spesso parlano di vie d’acqua per raggiungere l’area dove
sorgerà il sito; inoltre dai risultati del recente referendum
riguardo la valorizzazione dei navigli, i milanesi hanno accolto
con grande entusiasmo l’idea di restituire i corsi d’acqua a
Milano. Restituire… avete letto benissimo, non è un
errore di battitura ma non molti sanno che a Milano scorre un
labirinto di corsi d’acqua che si intersecano sotto la città. Già dal precedente articolo sulla tombinatura
del fiume Olona si è capito qual è stata la politica delle
giunte milanesi dell’ultimo secolo: coprire, nascondere e
cancellare il passato fluviale di Milano. Queste decisioni appaiono molto criticate al
giorno d’oggi; purtroppo l’aumento costante del traffico
automobilistico e l’inquinamento crescente delle acque (non
dimentichiamo che Milano fino al 2003 non disponeva di un
sistema di depurazione delle acque efficace) non lasciarono
scampo ai canali milanesi. Il sottosuolo di Milano, oltre a una ricca
presenza di acqua da fontanili e risorgive (gli utenti delle
metropolitane conoscono benissimo il problema della falda
acquifera per i frequenti allagamenti dovuti a questo fenomeno),
può vantare moltissimi corsi d’acqua sotterranei. Creare una mappa, o citarne tutti i nomi
sarebbe un lavoro da ingegnere esperto del servizio idrico
milanese pertanto mi limiterò a descrivere i tratti principali e
i rami più importanti. Naviglio Martesana, Seveso e Cavo
Redefosssi Giunto al Ponte delle Gabelle
(attuale viale Montegrappa angolo Melchiorre Gioia) entrava
attraverso i Bastioni in città, proseguiva lungo la via San
Marco fino a creare il “Tombone di San Marco” (el Tumbun in
dialetto) dove infine sfociava nella cerchia interna dei Navigli
nell’attuale via Fatebenefratelli. Il Seveso invece è un torrente che nasce a
Cavallasca (CO) sul monte Sasso e attraversa tutta la Brianza
fino ad entrare a Milano in zona Niguarda. Il corso è stato
deviato in antichità dai Romani per creare il Grande Sevese e il
Piccolo Sevese, due canali difensivi lungo le Mura repubblicane.
Nel 1471, quando la Martesana giunse alla Cascina de Pomm, il
Seveso venne deviato per ricevere le acque in eccesso della
Martesana fino al 1496 quando ,completata la Martesana, il
Seveso ne divenne un affluente. Il Cavo Redefossi nasce nel 1783 circa dal
Naviglio Martesana al ponte delle Gabelle con lo scopo di
evitare le esondazioni del naviglio nei periodi di piena
(ricordando che in quel punto il naviglio ha appena ricevuto le
acque del Seveso).
La situazione attuale: attualmente in
superficie scorre solo la Martesana fino a Cascina de Pomm; da
quel punto inizia il suo percorso sotterraneo lungo la via
Melchiorre Gioia. Il Seveso sul territorio di Milano è
interamente tombinato; inizia il suo percorso sotterraneo in via
Ornato e sfocia nella Martesana alla confluenza tra via
Carissimi e via Gioia. Nonostante il suo percorso sotterraneo riesce
spesso a far parlare di sé per le continue esondazioni in zona
Niguarda che avvengono con una frequenza impressionante al
minimo aumento di portata; la costruzione del Canale Scolmatore
di Nord – Ovest e di una griglia di decantazione prima della
tombinatura non hanno portato a un miglioramento sperato. Al Ponte delle Gabelle, interrato nel manto
stradale, esiste tutt’ora la diga che dà origine al cavo
Redefossi (vedi schema). La maggior parte delle acque della Martesana
viene sversata nel Redefossi che percorre sotterraneo tutta la
circonvallazione dei Bastioni (via Monte Santo, viale Vittorio
Veneto, viale Piave, viale Premuda e viale Monte Nero) fino a
Corso Lodi dove scorre sempre sotterraneo fino a rivedere la
luce a San Donato Milanese e San Giuliano anche se in tempi
recentissimi si sta provvedendo alla tombinatura anche di questo
tratto. Dal Ponte delle Gabelle esiste ancora un
piccolo canale che porta una minima quantità d’acqua lungo la
via San Marco e da lì a mezzo del Cavo Borgonuovo
(che percorre la via omonima) a rifornire il Grande Sevese che
nasce sotto via Montenapoleone. Grande Sevese, Piccolo Sevese,
Ticinello e Vettabbia La Vettabbia è un canale che nasceva appunto
come detto in precedenza dalla confluenza del Grande e Piccolo
Sevese nell’attuale Parco delle Basiliche. Il suo percorso
puntava verso sud/est andando ad intercettare il Lambro. In
epoca romana, riceveva anche portata dell’Olona deviato dai
romani per rifornire la fossa difensiva occidentale. Il Cavo Ticinello (da non confondere con il
canale omonimo che scorreva al confine con la provincia di Pavia
da Abbiategrasso a Bereguardo) è un canale che trae le sue acque
dalla Darsena dal lato di Porta Ticinese. Era utilizzato come
canale scolmatore già da prima che venisse scavato il Naviglio
Pavese. Il suo percorso è parallelo alla Vettabbia in uscita da
Milano andando a sfociare nel Lambro Meridionale. La situazione attuale: probabilmente il
percorso di questi canali è la parte più affascinante di tutta
la ricerca poiché ne esiste ancora buona parte in pieno centro
anche se è stata completamente assorbita e celata nel manto
stradale. Il Grande Sevese scorre tutt’ora per il centro
cittadino; il rifornimento d’acqua è assicurato dalla minima
portata garantita dal canale sotterraneo di via San Marco
(derivato dalla Martesana) che fa giungere le acque in via
Montenapoleone (attuale inizio del Grande Sevese) tramite il
Cavo Borgonuovo, sotto l’omonima via. Da via Montenapoleone raggiunge piazza San
Babila e completamente interrato arriva in via Larga (a pochi
passi dal Duomo!!!) e da lì percorrendo le piccole vie del
centro giunge al Parco dietro la basilica di San Lorenzo dove
incontrandosi con il Piccolo Sevese formano il canale della
Vetra che, sempre sotterraneo, sfocia nella Vettabbia. Il Piccolo Sevese invece scorre sotto il manto
stradale da Foro Bonaparte ang. Via Tivoli, alimentato
probabilmente dalla Roggia Castello che arriva da nord passando
a fianco del cimitero Monumentale.
L’attuale roggia Vettabbia (molto limitata se
si pensa che in passato era un canale navigabile!) nasce appunto
sotto il parco delle Basiliche dal canale della Vetra. Percorre interrata via Calatafimi, via Col
Moschin e via Castelbarco. Esce allo scoperto in viale Toscana
angolo Via Bazzi (coperto però da un cartellone pubblicitario!)
e a cielo aperto attraversa il quartiere ex OM (quartiere
Spadolini), il Vigentino fino a sfociare nel Redefossi dopo
Melegnano. Il Cavo Ticinello invece è molto più
misterioso rispetto alla Vettabbia. Sappiamo che in Darsena esce dalle chiuse
presenti verso piazza XXIV Maggio, attraversa sotterraneo il
monumento del Cagnola di porta Ticinese e imbocca viale Col di
Lana. Da lì il suo percorso risultava in passato
scorrere parallelo, senza incrociarsi, con la Vettabbia. Oggi
non si riesce a ben capire se i due corsi scorrano ancora
separati o si uniscano per questo breve tratto. Percorrendo la via Bazzi, esce allo scoperto
tra via De Missaglia e il quartiere Selvanesco e sfocia nel
Lambro Meridionale. Nella prossima parte prenderemo in
considerazione la Cerchia Interna, l’Olona e il Lambro. A
presto. Cerchia Interna dei Navigli, Naviglio
del Vallone, di San Gerolamo e Morto La cosiddetta cerchia dei Navigli derivava
dall’antico fossato difensivo medievale del 1156 ad opera di
Guglielmo da Guintellino creato per difendere Milano dalle
incursioni del Barbarossa. Quando il Naviglio Grande (1272 ca.) e il
Naviglio Martesana (1496) giunsero a Milano, si decise di
collegare la cerchia interna a questi due corsi per sfruttare le
vie d’acqua per il trasporto del marmo per la costruzione del
Duomo. Le acque della Martesana, dopo il Tombone di
San Marco, si immettevano nella cerchia interna in via
Fatebenefratelli, percorrevano piazza Cavour, via Senato, via
San Damiano, via Visconti di Modrone, via Francesco Sforza, via
Santa Sofia, via Molino delle Armi, via de Amicis e via
Carducci. Nell’attuale via Francesco Sforza all’altezza
di via Laghetto, fu costruito il porto di approdo per i marmi di
Candoglia del Duomo; questo “approdo” prese il nome di Laghetto
di Santo Stefano, proprio accanto all’ospedale Ca’ Granda
(attuale Università Statale). Per collegare il Naviglio Grande dalla Darsena
alla cerchia interna fu costruito il Naviglio del Vallone, o
anche conosciuto come Viarenna, dal nome della prima conca al
mondo costruita (1439 ca.). Il Naviglio del Vallone sottopassava
i Bastioni dell’attuale via Gabriele d’Annunzio e tramite
l’attuale via Conca del Naviglio (vedi foto di apertura)
andavano ad intercettare la fossa interna all’angolo con via
Molino delle Armi. Il Naviglio Morto invece era un tratto di
Naviglio nell’attuale via Pontaccio, un tratto facente parte
dell’antica cerchia interna del 1156 che andava a rifornire il
fossato del castello. Con la dismissione di questo compito
difensivo rimase “chiuso” in via Pontaccio e prese appunto il
nome di Naviglio Morto. Stessa sorte per il Naviglio di San Gerolamo
della cerchia interna che rimase attivo lungo la via Carducci,
terminava nell’attuale piazza Cadorna. La situazione attuale: con il PRG (Piano
Regolatore) Beruto del 1884 venne pianificata la chiusura della
fossa interna. I primi tratti ad essere coperti furono il
Naviglio Morto e il Naviglio di San Gerolamo nel 1894. La
cerchia interna invece venne coperta nel biennio 1929-30. Il
tratto da via Fatebenefratelli a via Molino delle Armi, compreso
il Naviglio del Vallone venne coperto.
Olona e Lambro Meridionale
Già dall’epoca romana veniva utilizzato come
canale di scarico fognario (infatti ne deriva il suo nome come
Lambro Merdario). La funzione del Lambro Meridionale potrebbe
esser paragonata alla ben più famosa Cloaca Maxima di Roma. Riceveva lo spurgo della città tramite un
canale che percorreva via Conca del Naviglio e , ricalcando il
percorso del Naviglio Grande, lo intercettava nell’attuale San
Cristoforo. Con lo scavo del Naviglio Grande, uno scarico
del Naviglio stesso divenne la sua foce. Dal 1930 circa
ricevette anche le acque dell’Olona sempre a San Cristoforo
venendo canalizzato nel suo percorso attuale. La situazione attuale: Il punto dove nasce il
Lambro Meridionale è ancora oggi visibilissimo; le chiuse del
Naviglio Grande sotto il ponte ferrato della ferrovia a San
Cristoforo danno origine al canale che pochi metri dopo la
nascita riceve le acque dell’Olona provenienti dalla
circonvallazione. Il colatore prosegue scoperto e canalizzato
lungo le vie Malaga e Santander. All’incrocio con viale
Famagosta inizia la tombinatura che scorre lungo via San Vigilio
e via San Paolino. Attraversa scoperto l’autostrada A7 e il
deposito della metropolitana a Famagosta. In via Boffalora
riceve le acque del Deviatore Olona. Sottopassa il Naviglio
Pavese vicino a Chiesa Rossa (ricevendone anche parte di
portata) e lascia la città in direzione Rozzano sempre a cielo
aperto. Dopo aver attraversato il pavese sfocia nel Lambro a
Sant’Angelo Lodigiano. Il Lambro Molti, per differenziarlo dal Colatore Lambro
Meridionale, preferiscono indicarlo come Lambro Settentrionale.
Ma il suo nome originale è Lambro. Nasce dai Monti del San Primo
a Magreglio. Arriva da Monza attraverso Cologno Monzese e nella
zona di Cascina Gobba sottopassa il Naviglio Martesana
ricevendone le acque in eccesso. Entrato nel territorio comunale
di Milano attraversa il parco Lambro, viale Forlanini, Cascina
Monluè ed esce in zona Peschiera Borromeo. A Melegnano riceve le
acque della Vettabbia e Cavo Redefossi, mentre a Sant’Angelo
Lodigiano riceve il Colatore Lambro Meridionale. A Senna
Lodigiana confluisce nel Po. La situazione attuale:
A chi fosse interessato ad approfondire
l’argomento consiglio la lettura del libro: “Viaggio nel
sottosuolo di Milano tra acque e canali segreti” di M. Brown, A.
Gentile e G. Spadoni – Editore Comune di Milano, non più
disponibile in commercio ma a disposizione presso le biblioteche
comunali rionali di Milano e il consorzio di biblioteche CSBNO,
da cui sono state tratte la maggior parte delle immagini di
questo articolo e con cui mi sono documentato per scriverlo.
|